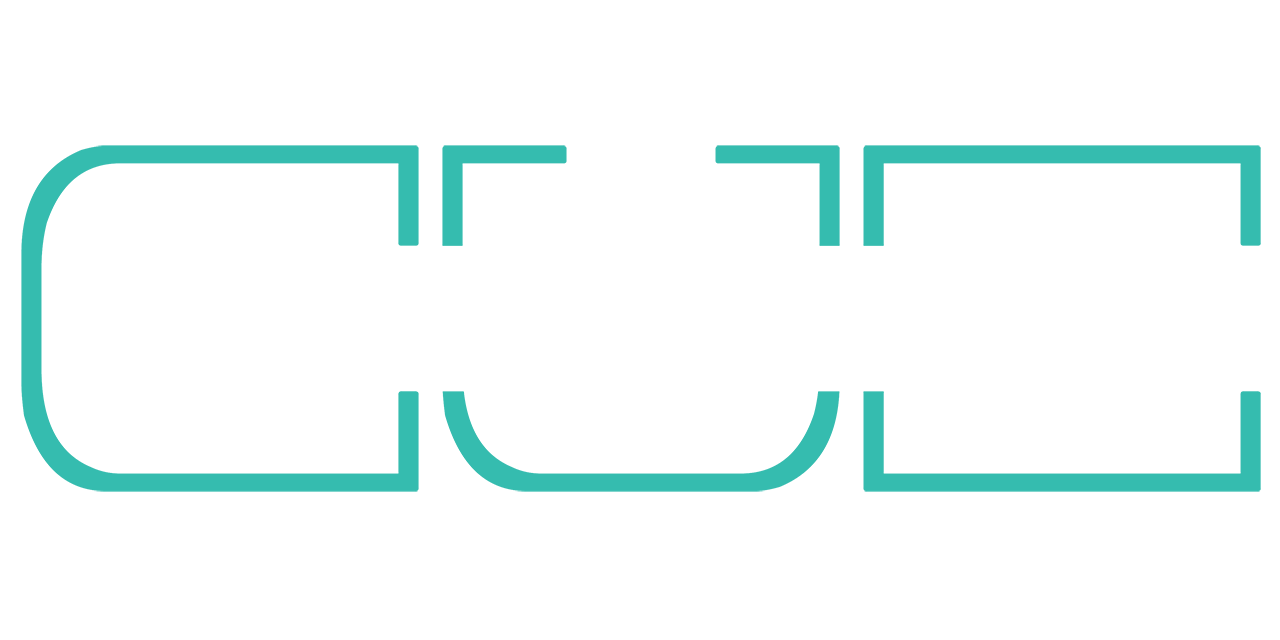Grado, scoperte antiche palizzate che rivelano 5000 anni di variazioni del livello del mare

Palizzate ritrovate (Canva) - marinecue.it
L’ultima scoperta effettuata nella lagua di Grado, mostra chiaramente come sia cambiato, in oltre 5000 anni, il livello del mare.
Un sorprendente ritrovamento nella cittadina lagunare di Grado, in Friuli Venezia Giulia, ha permesso agli studiosi di ricostruire l’evoluzione ambientale, e le variazioni del livello del mare, lungo la costa nord-orientale dell’Adriatico. Trattandosi di tre antiche palizzate in legno, datate fra il I e il VI secolo d.C., le quali hanno offerto una finestra privilegiata sull’interazione millenaria, fra l’uomo e l’ambiente marino. Il cui studio, pubblicato su “Scientific Reports”, è frutto della collaborazione fra Università di Bologna, INGV, OGS, e la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia.
Attraverso un’analisi multidisciplinare, i ricercatori hanno elaborato modelli numerici in grado di descrivere la variazione del livello del mare, negli ultimi 5 mila anni. Dati fondamentali per comprendere come l’Adriatico settentrionale, si sia trasformato nel tempo, poiché consentono di collegare l’evoluzione geomorfologica ai fenomeni naturali, e alle azioni dell’uomo. Le palizzate, originariamente costruite per proteggere le coste dall’erosione, hanno così assunto un nuovo ruolo: ovvero, diventar testimoni dell’adattamento ambientale, e delle trasformazioni del territorio.
La più antica delle strutture, risalente al I o II secolo d.C., era composta da tavole di legno disposte, in modo da creare una barriera continua: motivo per cui, gli studiosi ritengono servisse come contenimento per i materiali di bonifica, fra cui macerie e resti domestici, impiegati per innalzare il suolo costiero. Un’operazione che, avvenuta in un’epoca in cui il livello del mare era circa 1,2 metri più basso dell’attuale, testimonia una precoce capacità dell’uomo romano di modellare l’ambiente a proprio vantaggio.
La seconda palizzata, datata invece con metodo dendrocronologico al 566 d.C., racconta una storia diversa. Su di essa, infatti, son stati trovati segni di attacco della Teredo navalis, un mollusco che vive solo nei legni sommersi; indicando perciò, che a quell’epoca il livello del mare era inferiore di circa 80-90 centimetri, rispetto a oggi. Suggerendo un progressivo innalzamento marino, al quale gli abitanti tentarono tuttavia di porre rimedio, con opere di difesa costiera.
Una struttura come protezione
Accanto alle prime due barriere, è stata individuata una terza palizzata di età analoga, probabilmente destinata a consolidare le strutture del Castrum di Grado. Scoperta, questa, che mostra come le opere lignee non fossero solo difensive, ma parte integrante delle infrastrutture urbane, riflettendo una pianificazione territoriale avanzata per l’epoca.
L’evoluzione della laguna gradese è quindi il risultato dell’interazione fra fenomeni naturali, e azione antropica, poiché dopo l’ultima espansione glaciale – di circa 20 mila anni fa –, l’uomo ha progressivamente modificato il paesaggio costiero. E le bonifiche e le costruzioni lignee, ne son un chiaro esempio, mostrando come la linea di costa sia stata continuamente adattata alle esigenze economiche e ambientali, delle comunità locali.

Collaborazione scientifica, e tutela del territorio
Le indagini, realizzate da “ArcheoTest S.r.l.” per conto di “Irisacqua S.r.l.”; e sotto la direzione della Soprintendenza, s’inseriscono in un ampio programma di archeologia preventiva. La collaborazione fra enti accademici e istituti di ricerca, ha permesso d’integrare dati storici, fisici e geologici, che saranno utili per la tutela del patrimonio lagunare, e per la gestione sostenibile delle coste.
Come riportato anche dal sito magazine.unibo.it, lo studio rappresenta un contributo fondamentale per comprendere le dinamiche di variazione del livello del mare, nell’Alto Adriatico. E le palizzate di Grado, perfettamente conservate, non solo raccontano un frammento di storia romana e altomedievale, ma offrono anche un modello per future ricerche sull’impatto climatico, e sull’adattamento dell’uomo ai mutamenti ambientali.