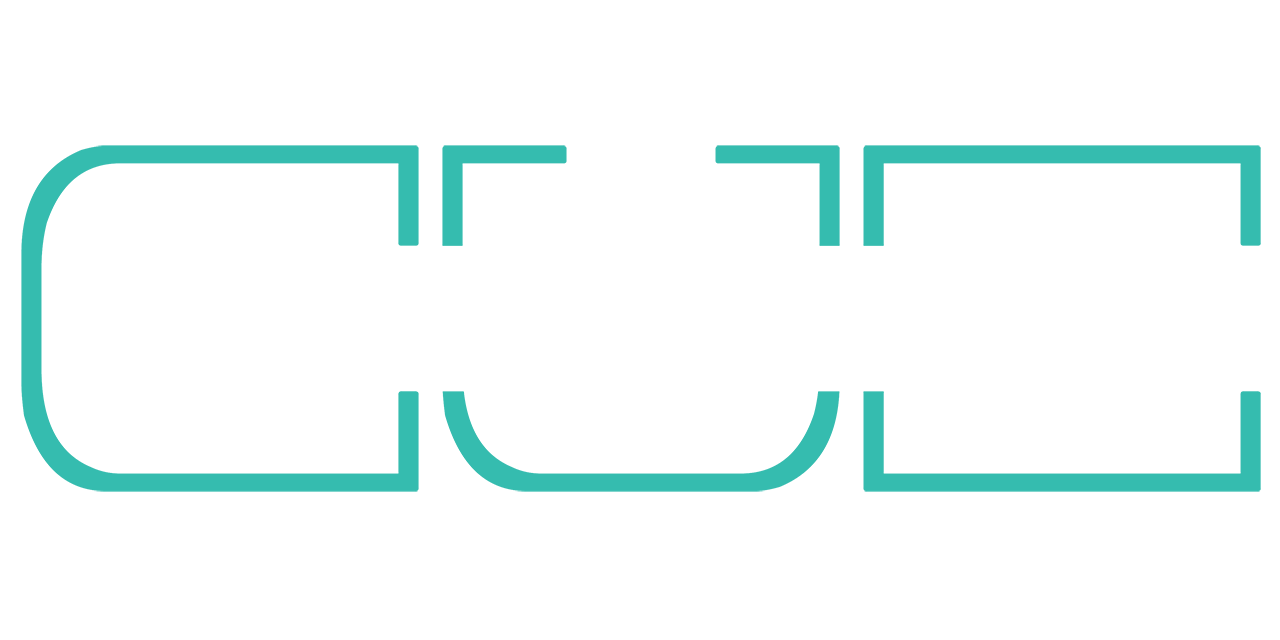Campi Flegrei, una nuova notizia allarma tutti | Esplosioni in mare e invasione di enormi quantità di fango bollente

Illustrazione dei Campi Flegrei (Canva FOTO) - marinecue.it
La situazione non è assolutamente da sottovalutare. Si tratta di una caldera attiva, e le attività legate ad essa sono davvero tante.
I Campi Flegrei sono una vasta caldera vulcanica che si estende a ovest di Napoli, toccando aree come Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Il loro nome, che deriva dal greco e significa campi ardenti, e sono caratterizzati da fumarole, sorgenti termali e vapori caldi.
A differenza di un vulcano isolato come il Vesuvio, qui si parla di un sistema complesso, formato da una moltitudine di crateri, coni e depressioni. Eventi eruttivi colossali avvenuti decine di migliaia di anni fa, come l’Ignimbrite Campana e il Tufo Giallo Napoletano, hanno plasmato il territorio.
Uno dei fenomeni più caratteristici della zona è il bradisismo, cioè il lento e continuo sollevarsi e abbassarsi del suolo, accompagnato da piccole scosse sismiche. Questi movimenti, frutto di dinamiche profonde legate a gas e magma, sono monitorati con grande attenzione dall’Osservatorio Vesuviano e dalla Protezione Civile.
L’ultima eruzione risale al 1538, quando nacque il Monte Nuovo, ma la storia geologica e l’attività attuale dimostrano che i Campi Flegrei sono tutt’altro che inattivi. Oggi rappresentano una delle aree vulcaniche più sorvegliate al mondo.
Un vulcano che non smette di sorprendere
Nei Campi Flegrei il terreno sembra avere un respiro tutto suo: si alza e si abbassa, rilascia gas caldi e accompagna il tutto con scosse di terremoto leggere ma frequenti. Un nuovo studio firmato da CNR-IGG, INGV e la società Steam, pubblicato su Solid Earth, indica che sotto la Solfatara, tra 2,7 e 4 chilometri di profondità, esiste un acquifero intermedio che si sta lentamente riscaldando e pressurizzando. Una sorta di serbatoio nascosto che potrebbe spiegare i movimenti del suolo e la sismicità che negli ultimi mesi hanno fatto discutere.
L’ipotesi è che questo bacino sotterraneo, scaldato dal degassamento magmatico, agisca come una gigantesca pentola a pressione. Una descrizione che rende l’idea: il vapore e i gas si accumulano finché la copertura rocciosa fatica a trattenerli. Proprio qui, nella zona della Solfatara, il rischio non riguarda solo il magma in risalita, ma anche possibili esplosioni freatiche, cioè improvvise liberazioni di vapore che potrebbero sollevare fango e detriti bollenti verso la superficie.

Possibili scenari futuri
Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il rapporto descrive scenari che, pur restando ipotesi, non lasciano indifferenti. Se la pressione dell’acquifero dovesse superare la resistenza delle rocce, si potrebbe generare un’esplosione idrotermale capace di spingere fiumi di fango rovente fuori dal cratere della Solfatara fino a raggiungere la costa.
Lo sciame sismico del 31 agosto e del 1° settembre, con un evento di magnitudo 4.0 e un improvviso abbassamento del suolo di circa 2 centimetri all’Accademia Aeronautica, è visto dagli studiosi come un possibile segnale della complessità in atto. Per prevenire conseguenze peggiori, i ricercatori propongono un monitoraggio continuo e mirato di temperatura e pressione dell’acquifero, unito allo studio chimico dei gas e a eventuali interventi tecnici, come l’uso controllato di vecchi pozzi geotermici per ridurre l’accumulo di energia.