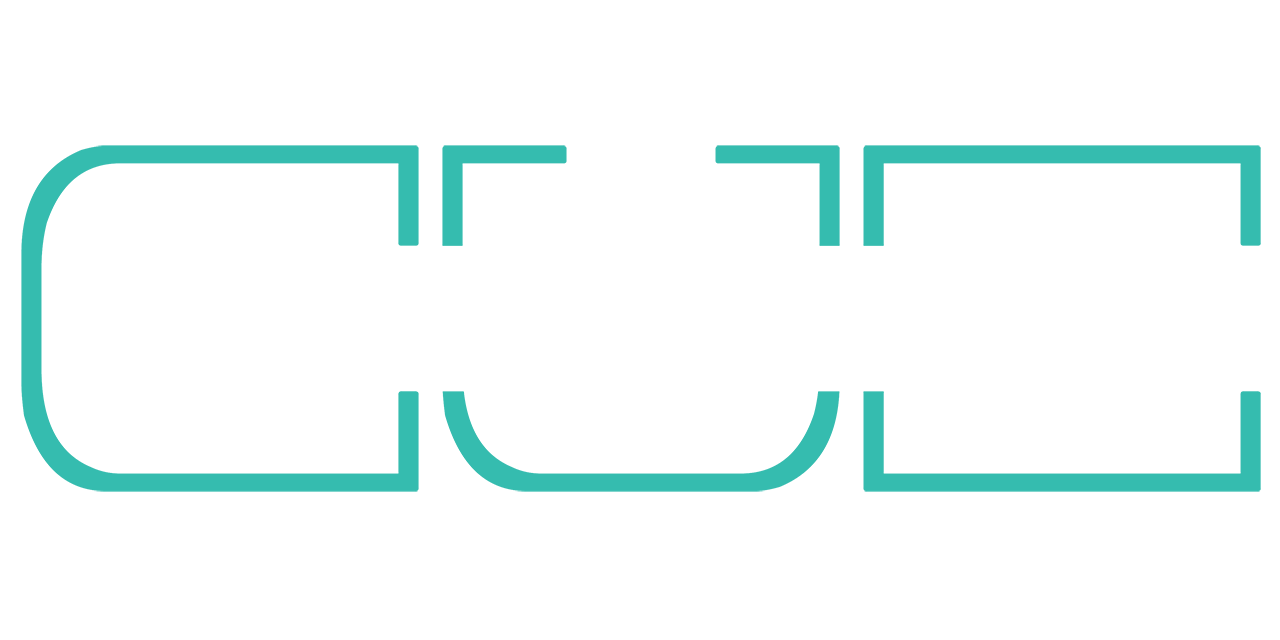Pesci, ormai non si mangiano più | Stanno finendo tutti per colpa dei collezionisti: finiscono come soprammobili

Pesci, la riserva naturale che li protegge (Freepik Foto) - www.marinecue.it
Ci sono storie che non si consumano sotto i riflettori, ma nelle pieghe del quotidiano, dove il tempo sembra scorrere più lentamente.
In questi spazi nascosti, lontani dal clamore delle cronache, sopravvivono creature che un tempo dominavano fiumi e tradizioni. Non sono leggende: sono frammenti viventi di un mondo che si sta riducendo.
Ogni volta che un habitat si restringe, l’effetto non riguarda solo gli animali che lo abitano. A scomparire è un’intera trama culturale fatta di miti, racconti, simboli e pratiche comunitarie. L’estinzione non spegne soltanto una forma di vita, ma intacca anche il patrimonio immateriale che la circondava.
Da decenni l’uomo procede su un doppio binario: da una parte sfrutta, altera, impoverisce; dall’altra conserva, alleva, protegge. È una contraddizione che emerge in maniera lampante quando si osserva la sorte di alcune specie che, pur essendo quasi sparite nei loro fiumi originari, oggi prosperano in spazi costruiti dall’uomo.
Il paradosso è affascinante e inquietante allo stesso tempo: creature che avrebbero bisogno di chilometri di acqua libera e corrente oggi si muovono lente in stagni artificiali, giardini privati o bacini religiosi. Un fenomeno che solleva domande etiche, ecologiche e scientifiche sul significato stesso di conservazione.
Un patrimonio invisibile
In Thailandia, lontano dal corso del Mekong, esistono vere e proprie popolazioni parallele di pesci giganti. Alcuni vivono nei laghetti dei templi, dove vengono considerati sacri e nutriti dai fedeli. Altri si trovano negli incubatoi governativi, nati negli anni Ottanta per contrastare il crollo delle popolazioni naturali. Poi ci sono gli allevatori privati, i collezionisti, i parchi di pesca sportiva: tutti custodi inconsapevoli di un patrimonio unico.
Il dato sorprendente è che, secondo le stime degli scienziati, questi esemplari allevati in cattività non sono pochi: si parla di oltre un milione di pesci gatto giganti del Mekong, un numero che supera di migliaia di volte la popolazione residua in natura. È un archivio biologico straordinario, che però resta invisibile e frammentato, distribuito in stagni domestici, vasche religiose e allevamenti commerciali. Una ricchezza potenziale, ma priva ancora di una strategia coordinata.

Il nodo della genetica
La questione, tuttavia, non si risolve con i numeri. Un esemplare cresciuto in cattività non è identico a uno selvatico. Abituato a cibo regolare e assenza di predatori, sviluppa comportamenti e tratti che riducono le sue possibilità di sopravvivenza in un ambiente naturale complesso. Questo fenomeno, noto come “domesticazione involontaria”, è uno dei principali ostacoli alla reintroduzione. A ciò si aggiunge il rischio genetico. Quando pochi individui vengono utilizzati come base riproduttiva, le generazioni successive finiscono per condividere lo stesso corredo genetico. Si crea così un collo di bottiglia evolutivo, che riduce la diversità e rende la popolazione vulnerabile a malattie, cambiamenti ambientali e nuove minacce. È la stessa dinamica che ha portato alla fragilità di molte specie animali allevate intensivamente. Senza un monitoraggio genetico accurato, liberare questi pesci nei fiumi significherebbe rischiare di indebolire ulteriormente le popolazioni selvatiche rimaste.
Eppure, nonostante i rischi, questa enorme riserva in cattività rappresenta forse l’ultima possibilità. Gli studiosi ipotizzano programmi di selezione genetica, incroci mirati e utilizzo di tecniche come il DNA ambientale per mappare la variabilità delle popolazioni presenti negli allevamenti. L’obiettivo è chiaro: trasformare questi pesci allevati in una risorsa di rinforzo, capace di sostenere le comunità selvatiche residue. Ma nessun piano avrà successo senza affrontare il nodo principale: l’habitat. I giganti del Mekong sono pesci migratori che hanno bisogno di fiumi lunghi, sani e connessi. Senza corridoi fluviali liberi, senza la riduzione della pesca illegale e senza politiche di gestione delle dighe, la reintroduzione sarà solo un palliativo. La conservazione vera richiede un approccio integrato, in cui i collezionisti e gli allevatori diventino alleati, ma in cui il cuore dell’azione resti la tutela degli ecosistemi naturali. Il futuro di questi colossi d’acqua dolce dipende quindi da una scelta collettiva: considerarli reliquie da mostrare negli stagni, oppure restituire loro i fiumi che hanno plasmato per millenni. Solo nel secondo caso potremo dire di averli davvero salvati.