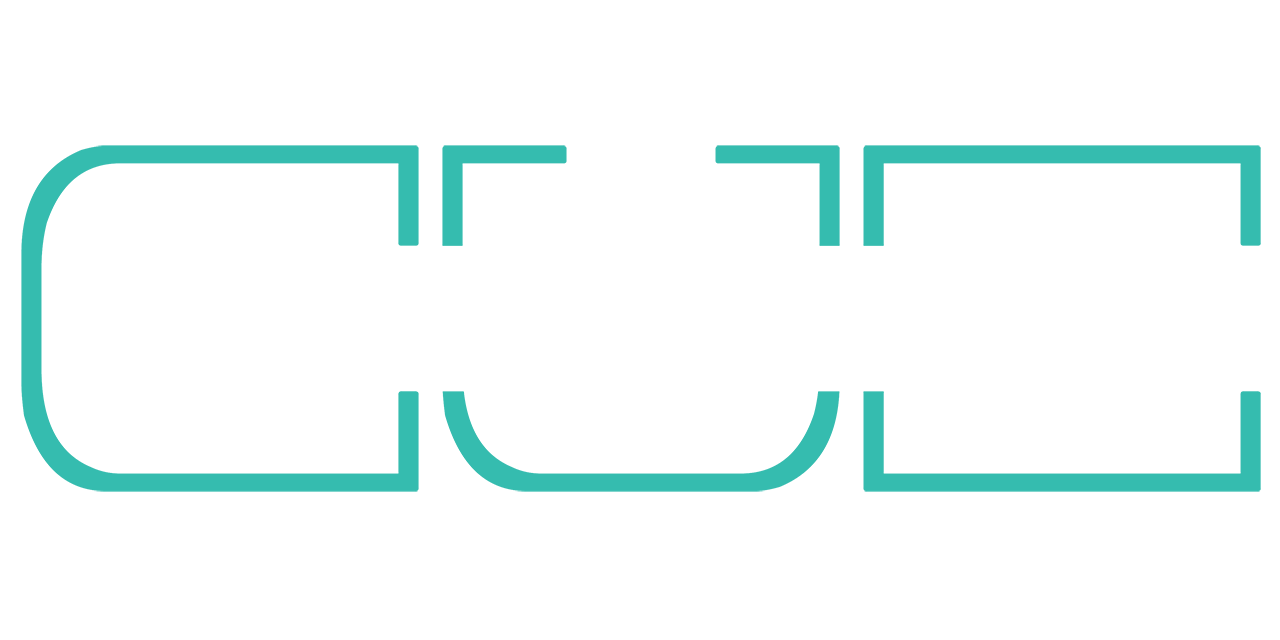Ondate di calore marino 2023: un campanello d’allarme per gli ecosistemi oceanici

Illustrazione di un mare caldo (Canva FOTO) - marinecue.it
I dati raccolti nel 2023 non sono molto rassicuranti, e gli ecosistemi marini ed oceanici sono in pericolo. Cosa succederà ora?
Negli ultimi anni si è parlato molto di ondate di calore, ma il 2023 ha portato la questione a un livello che pochi si aspettavano: il mare stesso ha iniziato a scaldarsi come mai prima. Non si tratta di qualche episodio isolato, ma di un fenomeno globale che ha coperto quasi la totalità della superficie oceanica.
Gli scienziati parlano di marine heatwaves, ondate di calore marine, ossia lunghi periodi in cui la temperatura dell’acqua sale ben oltre la norma. Il problema è che queste “fiammate” termiche non solo si stanno facendo più frequenti, ma anche più intense e durature. Nel 2023 alcune sono andate avanti per oltre 500 giorni consecutivi, un primato inquietante che abbraccia anche la vastità dell’evento.
Il punto critico è che tutto ciò non si limita a danneggiare coralli e pesci. C’è il rischio di effetti a catena su ecosistemi interi, con ripercussioni economiche per comunità costiere e industrie della pesca. Inoltre, questa tendenza potrebbe segnalare un cambiamento più profondo nelle dinamiche del sistema climatico globale.
La frequenza e l’intensità delle MHWs stanno crescendo a ritmi che le serie storiche non avevano mai registrato, e l’analisi dei dati satellitari conferma un trend netto e persistente.
Un fenomeno fuori scala
Gli eventi del 2023 hanno battuto ogni record, sia per la durata che per l’estensione e l’intensità. Secondo lo studio di Tianyun Dong e colleghi pubblicato su Science, la copertura ha raggiunto il 96% della superficie oceanica globale, con un’attività termica pari a 53,6 miliardi di “gradi-giorno” per chilometro quadrato, ovvero più di tre deviazioni standard sopra la media dal 1982. Alcune regioni sono state colpite in maniera particolare: il Nord Atlantico, il Pacifico orientale tropicale, il Nord Pacifico e il Pacifico sudoccidentale hanno concentrato il 90% delle anomalie di calore.
In termini di eventi singoli, il Nord Atlantico ha visto un’ondata iniziata a metà del 2022 e proseguita per ben 525 giorni, un’anomalia con un tempo di ritorno stimato in 276 anni. Nel Pacifico sudoccidentale, l’estensione spaziale e la durata hanno frantumato ogni precedente record, mentre nel Pacifico orientale tropicale le temperature sono salite fino a 1,63 °C sopra la norma durante l’inizio di El Niño.

Le cause dietro il surriscaldamento
L’analisi condotta con i dati ad alta risoluzione del progetto ECCO2 ha rivelato che non c’è un’unica causa, ma un intreccio di fattori regionali. Nel Nord Atlantico e nel Nord Pacifico hanno pesato soprattutto un aumento della radiazione solare dovuto a una minore copertura nuvolosa e uno strato misto più superficiale, capace di scaldarsi più rapidamente. Nel Pacifico sudoccidentale, oltre alla riduzione delle nuvole, si è registrato un incremento dell’advezione calda, mentre nel Pacifico orientale tropicale il ruolo principale lo hanno avuto i flussi oceanici anomali legati a El Niño.
Questi dati, uniti alla scala senza precedenti del fenomeno, portano i ricercatori a ipotizzare che il 2023 possa segnare l’inizio di un cambiamento più profondo nelle relazioni tra oceano e atmosfera. Una possibile soglia critica, un “tipping point” climatico, che se superato potrebbe alterare in modo duraturo gli equilibri del pianeta.